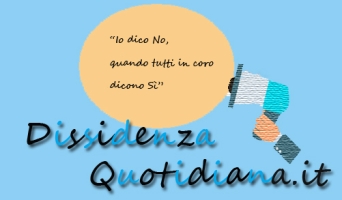di Federica Marengo sabato 15 marzo 2025

-Nell’ambito dello scavo e della messa in sicurezza e restauro dell’insula 10, Regio IX, che si trova nell’area centrale di Pompei, iniziato nel marzo 2023 e ora in fase finale , volto a riconnettere l’area con il tessuto urbano di via Nola, all’interno della Casa del Tiaso, (IX, 10 3) è stata scoperta dagli archeologi e dalle archeologhe una “Megalografia” ( dal Greco “Dipinto grande”) del I secolo a.C. in II° stile a tema dionisiaco. Si tratta della seconda Megalografia, ovvero del secondo ciclo di pitture a grande figura, rinvenuto a più di un secolo dalla scoperta dell’enorme fregio all’interno della Villa dei Misteri, ubicata fuori le porte della città.
L’enorme fregio affrescato dalle dimensioni quasi reali, che gira intorno ai tre lati dell’abitazione con il quarto lato aperto sul giardino, è stato scoperto in una grande sala della casa destinata ai banchetti e raffigura il corteo di Dioniso, dio del vino, composto da : baccanti rappresentate come danzatrici o come cacciatrici ,recanti ora un capretto sulle spalle ora una spada e le interiora di un animale nelle mani; giovani satiri con le orecchie appuntite che suonano il doppio flauto, mentre un altro satiro compie una libagione, ovvero un’offerta di vino in maniera acrobatica, versandolo dietro le proprie spalle da un corno potorio (usato per bere) in una patera (coppa bassa).
Al centro dell’affresco, invece, è rappresentata una donna con un vecchio sileno che impugna una torcia: è un’inizianda , ovvero una mortale che, con un rituale notturno, sta per essere iniziata ai misteri di Dioniso, dio che , morendo e rinascendo, promette altrettanto ai suoi seguaci.
Le scoperte, riguardanti Pompei, però, non sono finite. Recentemente, infatti, è stato pubblicato sulla rivista “Journal of Archaeological Science”, un articolo scientifico dal titolo: “Pompeian pigments. A glimpse into ancient Roman colouring materials”, riguardante un’indagine condotta sui pigmenti rinvenuti in alcuni contesti pompeiani, databili fra il III° secolo a.C. e il 79 d.C., data dell’eruzione del Vesuvio.
La composizione dei pigmenti naturali e sintetici, inorganici e organici e la loro gamma cromatica è stata rivelata grazie a un’analisi non invasiva che combina la microscopia con la spettroscopia, attraverso cui si è scoperto come gli artisti dell’epoca mescolassero sapientemente le materie prime per ottenere una grande varietà di tonalità cromatiche.
Grazie a tale studio, è emerso l’utilizzo di un nuovo colore grigio in cui la presenza di barite e alunite, fornisce la prova dell’utilizzo in epoca antica, nel Mediterraneo, del solfato di bario.
L’indagine è stata condotta grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei , il gruppo di ricerca di Mineralogia e Petrografia del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio e gli studiosi del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università Federico II di Napoli.
Grazie a tale collaborazione , che prevede anche lo studio dei colori negli affreschi pompeiani, sono state effettuate analisi diagnostiche non invasive in coordinamento con le operazioni di restauro, proprio presso la stanza rossa della “Casa del Tiaso”.
©Riproduzione riservata