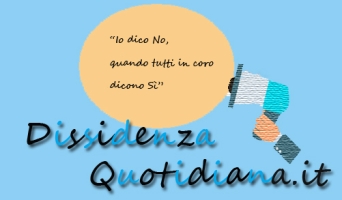La nona tappa del nostro tour attraverso il Decumano Maggiore del Centro Storico, lungo via dei Tribunali , è la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Costruita su iniziativa di una congregazione fondata nel 1604 da un gruppo di nobili napoletani allo scopo di raccogliere fondi per la celebrazione di messe in suffragio delle anime del Purgatorio, fu edificata nella zona detta: “ad Arco”, per la presenza di una torre medioevale, in seguito demolita,eretta tra Via dei Tribunali, Via Atri e Via Nilo. Il tema della morte, infatti, ricorre nella decorazione della facciata, ornata di teschi, ossa e clessidre, ideata e realizzata da Cosimo Fanzago nel 1652. Ancora oggi,una particolare forma di devozione è riservata ai teschi bronzei posti su pilastri all’ingresso della chiesa davanti ai quali vengono deposti quotidianamente dei fiori. Così come sono oggetto di venerazione i resti umani conservati nel cimitero sottostante l’edificio. L’interno, a navata unica con cappelle laterali, conserva dipinti del XVII° secolo di : Massimo Stanzione (la “Madonna delle Anime Purganti”),Luca Giordano (“La morte di Sant’Alessio”) e di Andrea Vaccaro ( il “Transito di San Giuseppe”). Le sale alle spalle dell’abside e la chiesa sotterranea ,con il vicino ipogeo ,costituiscono il Museo dell’Opera Pia Purgatorio ad Arco.
di Federica Marengo domenica 15 dicembre 2019

Foto: dissidenzaquotidiana.it
C’è un luogo a Napoli, dove la devozione e la pietà si fondono con l’attitudine dei partenopei all’ostentazione e alla teatralità, ma a anche al folclore e alla superstizione: è la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco,la nona tappa del nostro viaggio attraverso il Decumano Maggiore del Centro storico, lungo via dei Tribunali.
Giunti all’ingresso, siamo attratti dalla visione dei tanti fiori e delle candele poste dinanzi e ai lati di teschi bronzei appoggiati su mezzi pilastri, quindi, decidiamo di saperne di più ,unendoci a una gruppo di turisti italo-americani al seguito di una guida.
Il nostro Cicerone, una esperta di Storia dell’Arte barocca, ci spiega che la chiesa, concepita sin dalle origini su due livelli, superiore e inferiore, fu eretta nel 1616 su commissione di diverse famiglie nobili napoletane e su progetto di Giovan Cola di Franco e Giovan Giacomo Di Conforto, per fornire una sepoltura alle persone indigenti ,colpite dall’epidemia di peste che ammorbò la città durante il secolo, a partire dal 1605.
La famiglia che fornì il maggior apporto alla costruzione dell’edificio,fu quella dei Mastrillo, con i fratelli Geronimo e Francesco, i quali diedero impulso alla realizzazione della struttura, affinché si occupasse di opere pie come la scarcerazione dei poveri imprigionati per debiti d’affitto, la sepoltura dei defunti e le donazioni di abiti per i bisognosi, tuttavia diedero il loro contributo anche le famiglie Muscettola, Brancaccio, Caracciolo, Carafa e Carmignano.
La chiesa, prese la denominazione “ad Arco”, in quanto edificata nella zona detta “regio de arcu cabredato”, per la presenza di una torre medioevale, poi demolita, posta all’incrocio tra via Tribunali, via Atri e via Nilo.
La struttura fu abbattuta ai tempi di don Pedro di Toledo, che l’aveva fatta erigere per ampliare la strada e migliorare la viabilità per la nuova sede del tribunale,ovvero Castel Capuano, da lui istituita.
Tuttavia, alcuni storici, come Bartolomeo Capasso, Riccardo Filangieri , Candida Gonzaga e Giovanni Antonio Summonte dissentono, riportando la data a dopo la morte del sovrano spagnolo e spiegando la demolizione con il bisogno di ariosità del vicino palazzo della marchesa del Vasto.
Altri, poi, come il Capaccio,riferiscono che la torre fu abbattuta da don Pedro per via della falsa credenza per la quale all’interno vi dimorassero gli spiriti.
I lavori di costruzione della chiesa furono ultimati nel 1638, data nella quale la parte superiore dell’edificio fu consacrata ed aperta al culto, mentre quella inferiore fu completata nel Settecento per poi essere destinata alla sepoltura delle “anime pezzentelle”, grazie alla riconferma di tale diritto data da Isabella Mastrillo, che nel 1742 istituì lo “ius sepolturae” (diritto di sepoltura) in chiesa.
Entrambe le chiese rimasero aperte fino al terremoto dell’Irpinia del 1980, quando,chiusero per via della mancanza di stabilità dell’edificio del piano inferiore. Solo alcuni lavori di restauro, ne determinarono la riapertura al culto nel 1992.
All’esterno, l’edificio presenta una facciata decorata da anonimi con teschi sui fregi del portale e delle nicchie laterali ,mentre il portale e il tondo sovrastante, con il bassorilievo della “Madonna con le Anime del Purgatorio,” sono databili al Settecento e sono attribuiti al pittore e architetto barocco Cosimo Fanzago.
Dopo il breve cenno riguardante la storia della chiesa, fatto dalla nostra guida, è arrivato il momento di entrare nella chiesa superiore; quindi, varcatane la soglia, ci troviamo dinanzi a una navata unica con un transetto ridotto e cappelle laterali.
Il presbiterio e l’abside, invece, databili al 1669, sono decorati su disegno dell’architetto e scultore Dionisio Lazzari.

Foto: dissidenzaquotidiana.it
Sull’altare settecentesco , preceduto da una balaustra in marmo colorato , scorgiamo la tela di ispirazione caravaggesca, raffigurante la “Madonna delle Anime Purganti” di Massimo Stanzione, realizzata fra il 1638 e il 1642.
Sulla parete di fondo dietro l’altare, poi, troviamo la scultura del “Teschio alato” di Lazzari, mentre al di sopra vi è il dipinto del 1670, di Giacomo Farelli, rappresentate “Sant’Anna che offre la Vergine bambina al Padre Eterno”.
Nella parete absidale di sinistra , infine, vediamo il monumentale “Sepolcro di Giulio Mastrillo”, opera iniziata da Andrea Vaccaro e terminata nel 1672 dallo scultore Andrea Falcone, il quale si occupò di eseguire la statua inginocchiata del Mastrilli.
Spostandoci verso le quattro cappelle laterali, poi, scorgiamo sculture in legno di maestri ignoti e dipinti di artisti del Seicento napoletano, tra i quali, nella prima cappella di sinistra: “San Michele Arcangelo abbatte il demonio” di Girolamo De Magistro , databile al 1650, nella terza cappella di sinistra, la pala d’altare, risalente sempre allo stesso periodo, con raffigurata la “Morte di San Giuseppe” di Andrea Vaccaro e la prima cappella di destra con la “Morte di Sant’Alessio”di un esordiente Luca Giordano, risalente al 1661.
Sagrestia ed oratorio dell’Immacolata , infine, tutti alle spalle dell’abside della chiesa, ospitano il Museo dell’Opera Pia Purgatorio ad Arco, nel quale sono visibili oggetti liturgici, paramenti, calici, libri, suppellettili ed altri oggetti appartenenti ai secoli fra il Seicento e l’Ottocento.
Terminata la nostra visita nella chiesa superiore, quindi, percorrendo una scala posta a sinistra, dopo l’ingresso, raggiungiamo la chiesa inferiore, costruita in linea d’aria, in modo del tutto speculare a quella del Purgatorio ad Arco, sebbene per contrasto buia e spoglia, con lo scopo di dare sepoltura alle anime “pezzentelle” (povere) di Napoli.
Qui, in fondo alla navata unica, troviamo l’altare in piperno risalente al XVIII secolo e lungo le pareti laterali, alcune cappelle votive, mentre al centro del pavimento, realizzato dai fratelli Giuseppe e Donato Massa, già ideatori ed esecutori delle maioliche del chiostro delle Clarisse in Santa Chiara, vi è una grande tomba anonima.
A sinistra dell’aula, poi, in un angolo , scorgiamo un corridoio decorato con teschi, tramite il quale accediamo alla tomba di Giulio Mastrilli e a un secondo ambiente sotterraneo, fungente da ipogeo, con teschi e spazi per la sepoltura di corpi umani, parte del polo museale dell’Opera Pia Purgatorio ad Arco.

Foto: dissidenzaquotidiana.it
In questo luogo, concepito per rappresentare la discesa nel Purgatorio, prima dell’ascensione alla gloria divina, i fedeli, attraverso i secoli, hanno stretto un particolare legame con i resti mortali tanto da originare un culto al confine tra il paganesimo e la superstizione.
Tale rapporto è divenuto un vero e proprio culto: quello delle “anime pezzentelle”(dal lat, “petere”, “chiedere”), consistente: nell’adottare un teschio appartenente a un defunto tra i tanti qui seppelliti,poi ripulirlo, porlo su di un altarino per lo più a forma di casetta, di cartone o di legno, abbellirlo con santini e Rosari, gioielli, manufatti, oggetti della vita quotidiana, pregare per la sua anima e offrire Messe e donazioni, così da agevolargli il transito dal Purgatorio alla salvezza del Paradiso. Una volta salva l’anima, dunque, il defunto avrebbe a sua volta aiutato i benefattori esaudendo le loro richieste.
Tra i numerosi teschi, uno di questi richiama l’anima di Lucia D’Amore, sulla cui storia circolano numerose versioni, la più accreditata racconta fosse l’ unica figlia del principe Ruffano Domenico D’Amore, data in sposa contro la sua volontà al marchese Giacomo Santomago nel 1780-1790 . Per questo, poco dopo essersi sposata, ella si suicidò, o morì di dolore oppure annegata durante una tempesta. Fu quindi il padre, devoto della chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, a volere che fosse sepolta nell’ipogeo di quest’ultima e da allora, creatasi una particolare devozione intorno alle sue spoglie , le si rivolgono soprattutto donne in cerca di marito, avanzando richieste di grazie e intercessioni e offrendo ex voto.

Foto: dissidenzaquotidiana.it
Tuttavia il culto delle “anime pezzentelle”fu vietato dalla Chiesa nel 1969, perché ritenuto pagano, e l’ipogeo chiuso, anche se ,di fatto, esso continuò fino al 1980 quando il terremoto rese inagibile l’edificio, che fu chiuso e riaperto solo nel 1992 dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e che è a tutt’oggi visitabile
Usciti dalla chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, percorriamo a ritroso via dei Tribunali e via San Biagio dei Librai, per arrivare a Piazzetta Nilo e da qui, inoltrandoci in via Mezzocannone e in Vico San Marcellino , raggiungere la decima tappa del tour: la Basilica Santuario del Gesù Vecchio dell’Immacolata di Don Placido.
©Riproduzione riservata