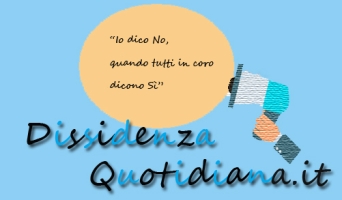di Federica Marengo sabato 13 luglio 2024

-Dal 21 maggio al 3 novembre , il Museo dell’Ara Pacis, a Roma, ospita presso lo spazio espositivo in via di Ripetta, la mostra: “Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma”, a cura di Orietta Rossini e Lucia Spagnuolo (curatrici con Salvatore Monda del catalogo “L’Erma” di Bretschneider), promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Roma – Archeologia Belle Arti e Paesaggio Dipartimento di Lettere e Culture Moderne – Università di Roma “La Sapienza” e INDA – Istituto Nazionale Dramma Antico e organizzata da Zetema Progetto Cultura.
Al centro dell’esposizione, la ricostruzione del mondo e della storia teatrale dell’antica Roma, con i suoi spettacoli, autori e attori, raccontata ai visitatori/visitatrici, in maniera diretta e interattiva, attraverso: interventi multimediali appositamente creati, riprese aeree, videomapping e attraverso la voce narrante di attori nei panni degli autori e degli attori del tempo.
La mostra è costituita da un percorso espositivo articolato in sette sezioni, durante il quale è possibile osservare oltre 240 opere rare , provenienti da venticinque diversi prestatori, tra cui : la coppa attica con una delle rare rappresentazioni di una processione in onore del dio Dioniso, divinità del teatro, prestata dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze; un altrettanto raro esemplare di maschera in terracotta, proveniente dal Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa e il “vaso di Pronomos”, prestato dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tra le testimonianze più rilevanti che riguardano il teatro antico.
Presenti tra i reperti ,anche maschere miniaturistiche della tragedia e commedia greca, provenienti da Lipari; alcune miniature teatrali mai esposte finora, provenienti da Tarquinia; statuine di attori, danzatori, giocolieri di area magnogreca e la rappresentazione della nascita di Elena dall’uovo su un vaso magnogreco appartenente a una serie con raffigurazioni relative alla commedia fliacica (genere tragicomico nato nelle colonie doriche della Megna Grecia ellenistica, fra il IV e il III secolo a. C.).
Non mancano poi testimonianze relative alla musica di scena, con strumenti musicali originali come: tibie, resti di cetra, crotali e sistri, alcuni dei quali sono stati riprodotti in copia per consentire ai visitatori/visitatrici di suonarli e modelli di maschere mai esposte a Roma, realizzati da un artigiano di Pompei; così come affreschi parietali di un camerino di una compagnia teatrale, provenienti da Nemi ; 12 gemme di epoca romana a soggetto teatrale ; il ritratto di Marcello e la maschera in bronzo di Papposileno, proveniente dalla collezione di una fondazione.
Tali opere, parte del percorso espositivo, fanno parte di una narrazione che segue un filo cronologico, che va dalle radici greche, siciliane, magno greche, etrusche e italiche del teatro romano, dall’origine religiosa del “ludus” e dai primi palcoscenici in legno, all’età augustea e alla “frons scenae” dei grandi teatri di epoca imperiale.
Anche le maschere sono esposte con un criterio narrativo-cronologico che parte dalle più antiche (V secolo a.C.) a quelle ellenistiche del III – II secolo a.C., fino a quelle di epoca romana, ciascuna corrispondente a caratteri e tipi umani poi ereditati dal teatro moderno e contemporaneo, quali: il misantropo, il giovane seduttore , il servo sciocco e i giovani amanti ostacolati nel loro amore dalla diversa condizione sociale.
Vediamo , quindi, come sono articolate le sette sezioni: la prima, intitolata “Genesi”, è dedicata al culto dionisiaco , alle radici della tradizione teatrale greca e al valore del teatro per la vita democratica di Atene; la seconda, invece, dal titolo: “Radici italiche e magnogreche”, racconta il contributo che l’Etruria, la Magna Grecia e i popoli italici apportarono alla nascita del teatro latino.
La terza sezione, dal titolo: “La commedia a Roma”, è incentrata sulla tradizione comica romana, sulla costruzione dei personaggi, e sul passaggio dalla commedia di Plauto ,con protagoniste vere e proprie maschere di tipi umani, a quella riflessiva e introspettiva di Terenzio, mentre la quarta sezione, intitolata : “La tragedia a Roma”, propone un focus sulla produzione tragica di epoca repubblicana con particolare riferimento a due suoi esponenti: Seneca e Nerone.
Nella quinta sezione, dal titolo : “I protagonisti e la musica”, invece, si raccontano le vite, spesso difficili, di attori, danzatori , musici e mimi (proprio a mimi e pantomimi di età imperiale viene riservato uno spazio specifico dell’esposizione), l’organizzazione degli spettacoli teatrali e delle compagnie e la produzione degli artigiani che realizzavano le maschere.
La sesta sezione, intitolata: “L’architettura”, offre un approfondimento sull’eredità monumentale lasciata dal teatro antico attraverso le rovine architettoniche. In particolare, si racconta del passaggio dalla Roma repubblicana a quella imperiale (I secolo a.C.) caratterizzata dalla costruzione a Roma dei primi teatri stabili , che condurrà in pochi decenni alla realizzazione di tre grandi teatri : il teatro di Pompeo (risalente al periodo fra il 61 e il 55a. C.), con una capienza di 20.000 posti, circondato da portici e giardini, di cui resta traccia solo nella topografia della Capitale e che grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma è al centro di un intervento video destinato a restare , dopo la mostra, patrimonio delle istituzioni curatrici; il teatro di Cornelio Balbo (13 a.C.), anch’esso perduto e il teatro di Marcello, coevo, e dedicato dall’imperatore Augusto al nipote.
Nella settima e ultima sezione, dal titolo: “Attualità del classico”, realizzata in collaborazione e con il contributo del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università di Roma “La Sapienza” e dell’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) troviamo una selezione di locandine storiche di spettacoli realizzati al teatro greco di Siracusa; montaggi video di messe in scena contemporanee e altre testimonianze materiali e fotografiche, relative al “Vantone” di Pier Paolo Pasolini (testo teatrale adattato in lingua dialettale romanesca del “Miles gloriosus” di Plauto) seguiti, in conclusione del percorso espositivo, da una panoramica sulla vitalità del teatro classico dal primo Novecento ai giorni nostri.
La mostra , infine, grazie all’impegno della Sovrintendenza Capitolina e alla collaborazione con Rai Pubblica Utilità, con il Dipartimento Politiche sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona di Roma Capitale e con la Cooperativa Segni d’Integrazione Lazio, è accessibile al più ampio pubblico possibile mediante percorsi e installazioni multisensoriali realizzati per ampliare i contenuti dell’esposizione e avvicinarli alle differenti esigenze dei visitatori. Per questo, saranno fruibili e scaricabili online audiodescrizioni, video LIS, disegni a rilievo e riproduzioni tattili di opere e di strumenti musicali ed è previsto un servizio di visite tattili e visite con interprete LIS gratuite.
©Riproduzione riservata